|
capacità di prevedere sequenze esecutive
di carpenteria in legno per getti in calcestruzzo
|
|
Conoscenze
di settore
|
|
| TECNOLOGIA EDILE: Conoscenze
chimico-fisiche sui materiali - Il legno da costruzione - Caratteristiche
del legno da costruzione |
 |
Arch.
Alberto Pedrazzoli
Andrea Sardena |
|
PESO
SPECIFICO
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Definizione
|
|
E’ il peso in Kg dell’unità di volume
del legno considerato (m3).
Il legno va prima essiccato (acqua inferiore al 15%
del peso complessivo).
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Osservazioni
|
|
Più alto è il peso specifico, più
il legno è compatto, robusto, duro, difficilmente
lavorabile ma suscettibile di buona finitura.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pesi specifici dei legni più comuni
|
|
Nome
|
kg/m3
|
|
Nome
|
kg/m3
|
|
Nome
|
kg/m3
|
|
|
|
|
|
|
ABETE
|
450
|
|
FRASSINO
|
750
|
|
PIOPPO
|
480
|
|
|
|
|
|
|
ACERO
|
670
|
|
LARICE
|
600
|
|
PLATANO
|
650
|
|
|
|
|
|
|
BETULLA
|
620
|
|
NOCE
|
700
|
|
QUERCIA
|
820
|
|
|
|
|
|
|
CASTAGNO
|
650
|
|
OLMO
|
700
|
|
ROBINIA
|
750
|
|
|
|
|
|
|
CIPRESSO
|
720
|
|
ONTANO
|
480
|
|
TASSO
|
900
|
|
|
|
|
|
|
FAGGIO
|
700
|
|
PINO
|
570
|
|
TIGLIO
|
520
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
LAVORABILITÀ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Definizione
|
|
Attitudine del legno ad essere tagliato e piallato
sia longitudinalmente che trasversalmente le fibre,
ottenendo elementi che non si frantumano e con le superfici
lisce
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Osservazioni
|
|
La lavorabilità varia non solo
da pianta a pianta ma anche nello stesso pezzo di legno
Normalmente il taglio e la piallatura
sono più agevoli lungo le fibre.
I legni pesanti e duri si tagliano
meglio se umidi, perché sono meno duri e non
si impastano. I legni leggeri e teneri invece con l’umidità
si rigonfiano e presentano maggior resistenza al passaggio
delle lame.
L’abete è un legno abbastanza
lavorabile.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FENDIBILITÀ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Definizione
|
|
Attitudine del legno ad essere spaccato conficcandovi
cunei, dando luogo ad una frattura con superficie netta,
piana e liscia.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Classificazione dei legni
|
|
Difficilmente fendibili
|
|
Mediamente fendibili
|
|
Facilmente fendibili
|
|
|
|
|
|
|
|
PLATANO
ACERO
BETULLA
FRASSINO
|
|
|
|
QUERCIA
CASTAGNO
FAGGIO
CIPRESSO
|
|
|
|
ABETE
NOCE
ONTANO
TIGLIO
PIOPPO
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DUREZZA
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Definizione
|
|
Capacità del legno di resistere alla penetrazione
da parte di oggetti. Si prova osservando l’impronta
lasciata sulla superficie da una sfera di acciaio, quando
è battuta su di essa.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Classificazione dei legni
|
|
Extra duri
|
|
BOSSO, EBANO, GUAIACO
|
|
|
|
|
|
|
Molto duri
|
|
CORNIOLO, TECK
|
|
|
|
|
|
|
Duri
|
|
ACERO, CILIEGIO
|
|
|
|
|
|
|
Discretamente duri
|
|
CASTAGNO, FAGGIO, MELO, NOCE, PERO, ROVERE
|
|
|
|
|
|
|
Mediamente duri
|
|
FRASSINO, OLMO, PINO
|
|
|
|
|
|
|
Teneri
|
|
ABETE, BETULLA, LARICE, ONTANO
|
|
|
|
|
|
|
Molto teneri
|
|
PIOPPO, SALICE, TIGLIO
|
|
|
|
|
|
|
Spugnosi
|
|
SUGHERO
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
RESISTENZA
MECCANICA
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Definizione
|
|
Capacità del legno di resistere alle sollecitazioni
di trazione, compressione, taglio, flessione, torsione
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Osservazioni
|
|
La resistenza a trazione è superiore se le fibre
sono parallele alla direzione della sollecitazione
|
|
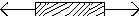
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
La resistenza a compressione è leggermente superiore
se le fibre sono perpendicolari alla direzione della
sollecitazione
|
|
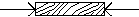
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Il legno resiste al taglio se le fibre sono perpendicolari
alla direzione della sollecitazione. Nel caso contrario
la resistenza è minima
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
La resistenza a flessione è maggiore quando
le fibre sono perpendicolari alla direzione dei carichi
applicati alla trave
|
|
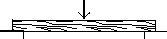
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
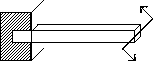
|
|
|
|
|
|
|
La resistenza a torsione è maggiore quando le
fibre sono perpendicolari alla sollecitazione e cioè
parallele all’asse della trave
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TENACITÀ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Definizione
|
|
Attitudine del legno di resistere alle sollecitazioni
dovute agli urti.
Sono molto tenaci le piante molto fibrose
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Classificazione dei legni
|
|
molto tenaci
|
|
poco tenaci
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FAGGIO, FRASSINO, OLIVO, QUERCIA
|
|
ABETE, BETULLA, CASTAGNO, PLATANO
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELASTICITÀ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Definizione
|
|
La capacità del legno di riassumere la forma
iniziale al cessare della sollecitazione.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Osservazioni
|
|
Sono più elastici e si piegano senza spezzarsi
i legni giovani, poco stagionati ed più umidi.
Per piegare il legno è quindi necessario bagnarlo
a fondo.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Classificazione dei legni
|
|
molto elastici
|
|
mediamente elastici
|
|
poco elastici
|
|
|
|
|
|
|
FRASSINO, OLMO
|
|
ABETE, FAGGIO, NOCE, PIOPPO
|
|
CASTAGNO, PINO, QUERCIA
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DEFORMAZIONE
DEL LEGNO
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Definizione
|
|
La deformabilità del legno è in funzione
del rapporto fra il ritiro radiale e il ritiro tangenziale
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Classificazione dei legni
|
|
a bassa deformabilità
|
|
a normale deformabilità
|
|
ad elevata deformabilità
|
|
|
|
|
|
|
CASTAGNO, MOGANO, NOCE
|
|
ACERO, FRASSINO, OLMO, ROBINIA, TEAK
|
|
ABETE, FAGGIO, LARICE, PIOPPO
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tipi di deformazione
|
|
RITIRO RADIALE

|
|
IMBARCAMENTO
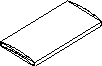
|
|
ARCUATURA
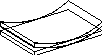
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
RITIRO TANGENZIALE

|
|
SVERGOLAMENTO
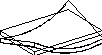
|
|
FALCATURA

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DIFETTI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Definizione
|
|
I difetti del legno sono collegati alle traversie,
difficoltà e malattie che la pianta ha subito
nel corso della sua vita.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Principali difetti
|
|

|
|
FENDITURE
|
|
|
|
|
|
|
|
Tagli che dall’esterno si prolungano verso il
centro del tronco. Sono dovuti al congelamento della
linfa.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

|
|
CIPOLLATURE
|
|
|
|
|
|
|
|
Distacchi tra i vari anelli di accrescimento, più
o meno estesi a tutta la circonferenza e a tutta la
lunghezza del tronco. Sono dovuti al gelo o all’azione
del vento che ha piegato spesso e fortemente l’albero
in una sola direzione.
Nelle essenze resinose i vuoti si possono riempire
di resina, determinando le tasche.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Canastro
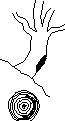
|
Legno di tensione

|
|
CANASTRO E LEGNO DI TENSIONE
|
|
|
|
Parti del legno di colore rossiccio (canastro) o bianco
argenteo (legno di tensione) dovute a sollecitazioni
costanti sulla pianta causate dal vento o dal peso proprio.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

|
|
LUNATURA
|
|
|
|
|
|
|
|
Anello che a causa del cattivo andamento di una stagione
non ha avuto il tempo di trasformarsi in durame ed è
quindi facilmente marcescibile.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tronco segato normalmente all’asse
dei monconi: NODI MOBILI O MORTI
|

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
NODI MOBILI O MORTI O A BAFFO
|
|
|
|
|
|
|
|
Monconi di rami morti, rimasti interni al fusto. Il
pezzetto di moncone non è collegato alla fibra
del legno per cui si leva facilmente e al suo posto
rimane un buco
|
|
Tronco segato parallelamente all’asse
dei monconi: NODI TRASVERSALI O A BAFFO
|

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ESSENZE
IMPIEGATE NELLE OPERE DI CARPENTERIA
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ABETE BIANCO
(Abies alba, famiglia Pinacee)
|
|
È diffuso nelle regioni montane dell’Europa
Centrale dai Pirenei alle Alpi ai Balcani. È
un albero che può raggiungere i 40/50 metri di
altezza.
Il legno è resinoso tra l’alburno e la
corteccia, tenerissimo e durevole, ha colore bianco
o giallastro e venature appena percettibili. Il legname
è sufficientemente elastico, ha scarsa flessibilità,
è resistente al coperto e nell’acqua, si
imbarca poco. In carpenteria viene comunemente usato
per travature ed armature nella realizzazione di solai
e tetti, per opere provvisionali di carpenteria e tavolame
per casseforme.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ABETE ROSSO
(Picea alba,
famiglia Pinacee)
|
|
È diffuso nell’Europa centrale e settentrionale,
dalla Lapponia alle Alpi ai Balcani. Il legno presenta
venature marcate e rossicce.
L’abete rosso, rispetto a quello bianco, ha una
migliore resistenza all’umidità ed ha una
maggior resistenza a trazione e compressione.
In carpenteria il tipo di impiego è analogo
a quello dell’abete bianco.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PINO DOMESTICO
(Pinus pinea,
famiglia Pinacee)
|
|
È diffuso lungo le coste del Mare Mediterraneo.
È un albero che supera raramente i 25 metri di
altezza.
Il legno è molto resinoso, a grana fine e fibre
diritte, è leggero e pieghevole.
Ha un ritiro modesto.
In carpenteria è impiegato per elementi strutturali
(travi e pilastri) di solai e tetti.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PINO LARICIO
(Pinus laricio,
famiglia Pinacee)
|
|
È una conifera spontanea in Corsica, Sardegna
e nell’Italia centro-meridionale. È un albero
alto fino a 40 metri.
Il legno presenta, molto duro, ha il cuore di colore
rossastro e l’alburno bruno chiaro. La tessitura
è media, la fibratura diritta.
In carpenteria è impiegato per elementi strutturali
(travi e pilastri) di solai e tetti.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PINO MARITTIMO
(Pinus pinaster,
famiglia Pinacee)
|
|
È diffuso nel Mediterraneo occidentale. È
un albero alto fino a 40 metri.
Il legno è composto da un alburno bianco e di
un durame rosso. È pesante, duro e molto resistente.
Presenta una tessitura grossolana e una fibratura diritta.
In carpenteria è utilizzato per elementi strutturali
(travi e pilastri) e per puntelli da miniera.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PINO SILVESTRE
(Pinus sylvestris,
famiglia Pinacee)
|
|
È diffuso nell’Europa centro-settentrionale
e nord-orientale. È un albero alto fino a 40
metri .
Il legno di colore rossastro con alburno giallo ben
distinto, sovente molto spesso. È dolce, resinoso,
tenerissimo,. La fibratura è irregolare. Il legname
è poco elastico, durevole, poco flessibile, imbarca
poco, è resistente al coperto e all’acqua.
In carpenteria viene comunemente usato per elementi
strutturali (travi e pilastri) di solai e tetti. È
uno dei migliori elementi teneri da costruzione.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
LARICE EUROPEO
|
|
È diffuso in Europa Centrale, dalle Alpi ai
Carpazi. È un albero alto fino a 40 metri. Il
legno ha un alburno di colore giallastro e cuore rosso
bruno. È duro, resinoso, durevole. È sufficientemente
elastico, poco flessibile, resistente alla variazioni
atmosferiche, immune da insetti. In carpenteria viene
usato orditure strutturali delle coperture.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CASTAGNO
(Castanea sativa — famiglia Fagacee)
|
|
È diffuso nell’Europa meridionale. È
un albero alto fino a 30 metri.
Il legno è di colore giallo bruno, con alburno
molto sottile. È duro e durevole ma facile a
spaccarsi. È poco elastico, ha media flessibilità,
è poco resistente alle variazioni atmosferiche.
In carpenteria viene usato per orditure strutturali
delle coperture e per opere provvisorie.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
QUERCIA
(Quercus robur — famiglia Fagacee)
|
|
Sotto questo nome sono comprese diverse specie: la
più usata in carpenteria è la farnia.
È diffusa in tutta l’Europa.
Il legno è di colore bruno dorato con alburno
di colore giallastro. È forte e pesante, molto
durevole, imbarca poco, resiste alla marcescenza.
In carpenteria un tempo lo si usava anche per elementi
strutturali (travi e pilastri), ora lo si trova solo
in tavoloni.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
AGGREGAZIONI
DI LEGNAME
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
La cellulosa, presente nella parete delle cellule del
legno, assorbe e perde facilmente umidità dall’ambiente,
facendo rigonfiare o restringere il legno, deformandolo
e provocando anche fessurazioni più o meno estese.
Aggregando parti di legno, incrociando o interrompendo
le fibre, rendendo impermeabile la superficie del legno
con opportuni trattamenti (vernici e impregnanti) si
possono ridurre o addirittura annullare sia l’assorbimento
di acqua da parte del legno sia le deformazioni conseguenti
alla variazione nel contenuto di umidità.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
LEGNO LAMELLARE
|
|
È ottenuto incollando lamelle di abete rosso
o di abete bianco o di pino. Le lamelle, dello spessore
di 25 ÷ 45 mm e piallate sulle quattro facce, vengono
tagliate a pettine sulle teste ed incollate tra loro
con apposite colle. Le travi lamellari hanno una sezione
rettangolare allungata e possono raggiungere lunghezze
considerevoli. Inoltre le loro caratteristiche meccaniche
sono costanti, per cui sono più affidabili delle
normali travi in legno. Le travi lamellari subiscono
inoltre particolari trattamenti che riducono l’assorbimento
dell’umidità, impediscono l’attacco
degli insetti e ne riducono l’infiammabilità.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
COMPENSATI
|
|
È un materiale ottenuto incollando fogli sottili
a fibratura incrociata. Il numero minimo di fogli è
tre. Si possono avere compensati con maggior numero,
sempre dispari, di strati per ottenere spessori fino
a 25 mm. I compensati con un numero elevato di strati
prendono il nome di MULTISTRATI.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PANIFORTI
|
|
Sono costituiti da due fogli di compensato con interposizione
di listelli di legno massello. Lo spessore complessivo
varia da 10 a 45 mm.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MASONITE - FAESITE
|
|
Sono dei pannelli costituiti da pasta di legno e collanti,
pressati ed trattati opportunamente. Gli spessori vanno
da 5 a 8 mm.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TRUCIOLARE
|
|
Sono dei pannelli costituiti da trucioli finemente
sminuzzati, mescolati a collanti e sottoposti a forti
pressioni. Gli spessori vanno da 3 a 25 mm. Hanno buona
stabilità dimensionale e una buona resistenza
alle sollecitazioni. Hanno il difetto di non permettere
gli incastri né i collegamenti con chiodi o viti.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|