|
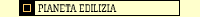

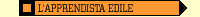 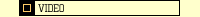
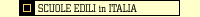
|
 |
L’articolo
La costruzione di un sistema di formazione
per l’apprendistato
A partire dall’esigenza espressa dalle parti
sociali nell’accordo del 1993 e nel Patto per il lavoro del 1996, e
quindi recepita dal governo attraverso l’articolo 16 della legge 196/97,
nel nostro paese è stato avviato un profondo processo di rivalutazione
dell’istituto dell’apprendistato, con il duplice obiettivo di aumentarne
la diffusione e rinforzarne la componente formativa.
Il rinnovato interesse per lo strumento si fonda
infatti sulla consapevolezza del ruolo centrale della formazione quale
fattore di crescita delle persone e quindi delle imprese. L’apprendistato
è uno strumento utile ad accompagnare e sostenere l’ingresso dei giovani
nel mondo del lavoro, aiutandoli a superare il gap scuola-lavoro con
un processo graduale di avvicinamento al “mestiere”. Inoltre il percorso
formativo dell’apprendista è arricchito da una formazione ester na all’impresa,
che deve aiutare a rielaborare e quindi a sistematizzare l’insieme di
competenze acquisite in modo informale sul luogo di lavoro, e soprattutto
deve sviluppare l’attitudine all’ "imparare ad imparare” in un’ottica
di longlife learning. A conferma del suo ruolo di strumento formativo,
l’apprendistato è stato inserito fra i canali attraverso i quali può
essere assolto l’obbligo di partecipazione ad attività formative fino
al diciottesimo anno di età, accanto alla scuola e alla formazione professionale
a tempo pieno.
Il “nuovo "apprendistato”, in realtà, presenta limitate modifiche rispetto
al quadro regolamentare tracciato dalla legge n.25 del 1955, ma è grazie
a tali modifiche che prende avvio un processo di riforma dello strumento
e di graduale messa a regime della formazione per apprendisti. Il timore
che l’introduzione del vincolo di 120 ore annuali di formazione esterna
all’impresa producesse una diminuzione degli occupati in apprendistato,
è stato del tutto smentito dai dati reali. Al contrario, dalla lettura
dei dati dell’Oml si rileva che nel 1997 sono stati occupati 437.757
apprendisti; dunque, dopo un lungo periodo di declino, il ricorso delle
imprese all’ap-prendistato è tornato ad aumentare, e dal 1997 al 1999
gli apprendisti sono cresciuti dell’11,3 per cento. E’ da sottolineare,
tra l’altro, come all’apprendistato facciano sempre più ricorso anche
settori non tradizionali, come il credito e le assicurazioni, all’interno
di un quadro evolutivo che vede questo strumento utilizzato anche per
professionalità di livello medio-superiore, al pari di quanto avviene
in altri paesi europei. Sussiste comunque uno squilibrio nella dislocazione
territoriale; infatti nelle regioni meridionali è presente solamente
il 15 per cento degli apprendisti esistenti a livello nazionale.
Questo dato, che è influenzato dalla concorrenza del contratto di formazione
lavoro, che per il sud offre condizioni di particolare vantaggio, produce
come conseguenza una forte dispersione dei giovani apprendisti sul territorio
e una maggiore difficoltà da parte delle regioni e delle provincie (che
devono organizzare l’attività formativa) ad allestire corsi di formazione
per un numero congruo di apprendisti aventi una qualifica omogenea.
Sembra invece che il “nuovo apprendistato” abbia comportato sostanziali
modifiche nell’ "identikit” dell’apprendista, rispetto allo stereotipo
tradizionale. Indagini realizzate dall’Isfol (sui giovani partecipanti
ai sei progetti sperimentali) mostrano che il tradizionale cliché dell’apprendista
dropout di 15-16 anni e addetto a mansioni dequalificate non è più valido:
oltre il 30 per cento degli apprendisti del 2000 possiede un diploma
di scuola secondaria, mentre l’età media è cresciuta e si aggira intorno
ai 20 anni. Il rapporto con il lavoro è complessivamente costruttivo;
solo il 17 per cento considera l’attività che svolge come “un modo per
guadagnare”, mentre il 51 per cento lo ritiene “come l’inizio di un
percorso professionale che intende proseguire”.
Il lavoro dell’apprendista non è dunque riconducibile alla categoria
“usa e getta”, e questo conferma l’importanza e la necessità di arricchire
questo percorso con una formazione esterna che ne potenzi ulteriormente
lo sviluppo professionale. Per dare attuazione alla riforma realizzata
attraverso l’articolo 16 della legge 196/97, e quindi avviare concretamente
il nuovo canale della formazione esterna per l’apprendistato, nel 1998
il ministero del Lavoro ha finanziato sei progetti sperimentali a valenza
nazionale per l’industria metalmeccanica e della installazione di impianti,
l’industria tessile, l’industria edile, le imprese artigiane, le imprese
aderenti a Confapi e quelle del settore turismo promossi sulla base
di accordi tra le organizzazioni sindacali e datoriali e finanziati
dal ministero del Lavoro con il contributo del Fse. Tali iniziative
sperimentali sono decollate nel corso del 1999: dei 19.000 apprendisti
destinati a essere coinvolti in interventi formativi biennali al 30
giugno scorso più dei due terzi avevano cominciato le attività e oltre
un quarto era già alla seconda annualità. Le sperimentazioni si sono
rivelate un banco di prova importantissimo per l’avvio delle attività
e la messa a regime di una legge che richiede di costruire un sistema
di formazione destinato a circa 400.000 giovani. Esse hanno permesso
di verificare tutti i complessi meccanismi e le procedure che devono
essere attuate per programmare e realizzare le attività corsuali, dalle
modalità di individuazione degli apprendisti, alle procedure per la
selezione dell’offerta formativa, dalla costruzione di una cultura della
formazione per gli apprendisti, alla messa a punto dei materiali didattici.
Grazie alle sperimentazioni ed ai meccanismi di accompagnamento che
sono stati previsti (comitati di coordinamento e di pilotaggio con le
parti sociali e con le regioni) su alcuni di questi aspetti è stata
fatta chiarezza.
Forse, però, l’indicazione più importante, in termini di sviluppo strategico
del sistema, riguarda i rapporti virtuosi che si sono attivati a livello
locale tra le amministrazioni e le parti sociali
Infatti la scelta di operare per un ampio coinvolgimento delle parti
sociali, sia a livello nazionale, nella predisposizione dei progetti
quadro, che a livello territoriale, nel coordinamento delle attività
di gestione, ha rinsaldato e in molti casi avviato una collaborazione
fattiva fra soggetti istituzionali e soggetti sociali in materia di
formazione professionale.
Si tratta di rapporti fondamentali per garantire una corretta gestione
dell’offerta formativa, in quanto assicurano uno stretto raccordo con
le esigenze delle imprese e dei lavoratori; tuttavia in passato questi
rapporti, pur essendo stati alla base della scelta costituzionale di
affidare alle regioni le competenze in materia formativa, non sempre
sono stati assicurati o correttamente intesi. È invece necessario che
nella programmazione delle attività vengano tenute presenti le esigenze
del territorio: questo obiettivo può essere raggiunto solo attraverso
un coinvolgimento pieno degli organismi che a livello territoriale rappresentano
le istanze del mondo del lavoro, e sotto questo aspetto l’introduzione
dell’apprendistato ha permesso di fare significativi passi in avanti.
Dunque, per la costruzione del nuovo canale di formazione per l’apprendistato
si sta lavorando lungo una doppia direttrice: da una parte la costruzione
dell’offerta formativa, prima attraverso il decollo delle iniziative
sperimentali e quindi con l’avvio dei Piani 2000 le attività finanziate
con i 200 miliardi messi a disposizione delle regioni dalla legge finanziaria
del 1999; dall’altra parte si sta operando per la definizione del quadro
normativo. I decreti sui contenuti delle attività formative (179/99),
sulle modalità di comunicazione (359/99), sul tutore aziendale (22/2000)
spesso sono nati in risposta a problematiche specifiche sorte durante
la realizzazione dei progetti sperimentali (emblematico il caso della
difficoltà di reperimento degli apprendisti per la mancanza di banche
dati dettagliate) e in ogni caso gli autori di tali provvedimenti hanno
tratto vantaggio dell’esperienza delle sperimentazioni.
Alla vigilia dell’avvio dei Piani 2000, per completare l’esame sull’andamento
e sui risultati dei progetti sperimentali si avverte la necessità di
un approfondimento specifico dell’analisi per singoli settori, che evidenzi
le specificità laddove le indagini Isfol hanno messo in risalto soprattutto
le tendenze generali.
Una risposta a questa esigenza viene offerta dal convegno che il Formedil
nazionale sta organizzando a Bologna per il prossimo 18 ottobre, con
l’obiettivo di esporre i risultati e le problematiche emerse nella realizzazione
del progetto per l’industria delle costruzioni.
|